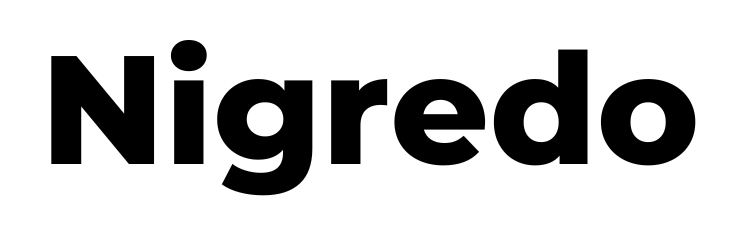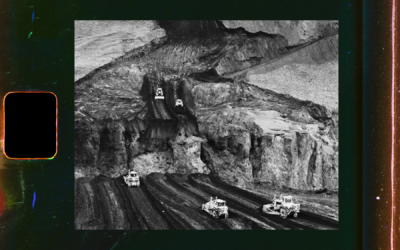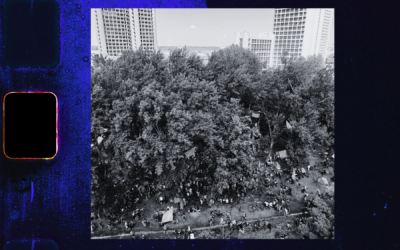Il contributo che segue differisce fortemente, soprattutto nel taglio e nella forma, da quelli a cui Nigredo ha abituato i suoi pochi lettori. Se fino ad ora ci siamo concentrati su elaborazioni teoriche o sul bilancio strategico di alcune traiettorie di lotta, sempre con lenti schiettamente analitiche, questo è uno scritto strettamente legato all’esperienza diretta. Sfogo, racconto, gesto terapeutico o diario con qualche linea di osservazione strategica, comunque, ma a partire da un vissuto recente e diretto da parte dell’autore. La lettera riguarda una condizione molto specifica, legata al contesto delle recenti mobilitazioni del precariato universitario, che a dire il vero, per ora, non hanno esattamente bucato la cappa del silenzio mediatico. Vuole però esprimere uno spunto più generale: lo stimolo a non trascurare come marginali le verità che ci consegna il nostro quotidiano, fatto di rapporti, conflitti, incontri, situazioni non sempre entusiasmanti o semplici da vivere, sia in termini politici che etici ed esistenziali. Le rotture situate e singolari che segnano i nostri tentativi di lotta, i nostri luoghi di lavoro, le passate e presenti vicende di militanza, con il loro corredo di fallimenti e delusioni, ma anche il banale e troppo spesso sottaciuto tentativo di procurarsi un reddito. Alcuni compagni scrivevano su per giù, decenni addietro, che il semplice fatto che siamo ancora costretti a vendere il nostro tempo al capitale per sopravvivere è un indicatore scandaloso del nostro livello di organizzazione. Non siamo avanzati di molto, ma quello che è certo e che non ci si può limitare a nascondere il problema sotto il tappeto. L’esaurimento e l’esasperazione, le rivendicazioni riformiste e gli accomodamenti a cui ci pieghiamo, le mobilitazioni in cui ci troviamo coinvolti nostro malgrado, il disprezzo verso chi ci sfrutta e le complicità che qualche volta ci sorprendono, sono tutte faccende che non sono estranee alla questione rivoluzionaria. E ancora meno a una definizione decente della questione etica, che è quasi la stessa cosa.
Lo scritto che segue è un gesto terapeutico da parte del sottoscritto, un compagno che ha provato, per pochissimi anni seguiti al dottorato di ricerca, a cavarsela nell’inferno del precariato universitario. Assegni di ricerca, docenze a contratto e altre amenità varie. Era un tentativo perso in partenza di prolungare quello stato di sospensione che è stato il dottorato stesso, vissuto come opportunità per immergersi nei libri e studiare le proprie cose, ben lontane dai crismi accademici, grattando un po’ di reddito per qualche tempo. La pretesa di applicare questa linea di condotta al lavoro universitario propriamente detto si è rivelata presto un’illusione autodistruttiva, per alcune semplici ragioni: l’Università non chiede semplicemente di stare alle regole di ingaggio, di osservarle formalmente, ma sollecita in modo continuo, tacito ed esplicito, mellifluo e ricattatorio secondo le occasioni, una piena adesione soggettiva ed intima al senso di queste regole, alla finzione sociale ridicola ed umiliante che queste regole riproducono. Vi ricordate la frase di Shakespeare citata da Marx sul denaro che rende belli i brutti, ringiovanisce, onora il ladro, rende la lebbra amabile e benedice il maledetto? Ecco, questo è il cuore del patto teatrale che deve essere rispettato dentro l’università: trattare gli imbecilli come autorevoli esperti, aspettandosi alla fine del percorso un uguale accomodamento nei propri confronti, dopo aver atrofizzato il cervello per alcuni decenni. Soprattutto non dire mai a quell’assortimento di sfruttatori e approfittatori che esaurisce pressocché interamente il corpo docente, per lo più di sinistra, anche radicale nei dipartimenti di scienze sociali, quello che fanno ogni giorno alla luce del sole.
Quel che è peggio è che tutto ciò viene compiuto quotidianamente senza vergognarsi, nello smarrimento assoluto ed incondizionato di qualsiasi sensibilità etica. Il recente tentativo di organizzare una mobilitazione di protesta contro i tagli alla ricerca e la riforma del settore universitario da parte del governo Meloni, ha rappresentato per me un rivelatore definitivo di faccende che erano già chiare. Mantenere una dirittura etica in un mondo lavorativo che congiura in ogni modo per impedirla è miracoloso, forse impossibile, ribellarsi e acquisire dignità in un ambito che perpetra l’auto-avvilimento continuo, è un risultato forse insperabile. Proviamo almeno a condividere, oltre uno sfogo, qualche riflessione strategica.
Nel corso degli ultimi mesi è stato avviato un tentativo di mobilitare il personale precario dell’Università, in prima battuta nella città di Torino, andando oltre le poche azioni simboliche e autoreferenziali portate avanti dalle cosiddette “Assemblee precarie”, essenzialmente un’accozzaglia di quei collettivi cittadini residuali e profondamente opportunisti che compongono la palude del “movimento”, soprattutto nelle sue diramazioni universitarie. La cifra del tentativo è: invece che addizionare in una generale e inconcludente sommatoria verbale qualsiasi fronte di mobilitazione ideologicamente distillabile nelle formule dei vari collettivi politici, senza alcuna presa reale su nessuno di questi fronti e ambiti, secondo l’inveterato ritornello della “convergenza delle lotte” (sempre immaginaria ed evocata), perché non partire dall’esperienza diretta? Muovere dagli incontri, da un reale radicamento in un luogo, l’università, che non è il laboratorio della cooperazione sociale cognitiva, ma un posto di merda molto vicino ad un’istituzione totale in cui però, per qualche ragione, si continua a rinchiudersi volontariamente alla ricerca di un traguardo che non arriva mai. In molti casi questo traguardo è il reperimento di un reddito, rispettabilissimo problema dei problemi, ma troppo spesso è la costruzione di una personalità sociale riconosciuta che dia senso e gratificazione ai poveri ego traumatizzati che attraversano a loro danno il succitato posto di merda. Quindi: non discorsi magari precisi (spoiler: nemmeno per sogno) o radicali (rimasticature riformiste da quattro soldi) sulle indubbie connessioni tra definanziamento universitario, militarizzazione, mutamenti geopolitici e causa palestinese, temi reali e drammatici ma non assumibili come punto di partenza di una lotta che voglia minimamente superare la familiarità di gruppetti militanti o la facondia narcisista dei quattro professori schierati a sinistra e barricaderi (sempre a parole e col culo ben piazzato, chiaro), bensì poche questioni semplici ed evidenti a tutti. La sfida è assumere come premessa un’inversione: non più fraseologia radicale vuota e iper-generale a fronte di pratiche inani ed estremamente timide, oltre che isolate, ma al contrario, parole d’ordine precise e pratiche fattive. Questa mobilitazione deve ancora affrontare la sua parte iniziale, quella di un blocco dell’attività didattica a settembre, e sono sicuro che, a fronte di una disponibilità astratta alla partecipazione da parte del corpo docente strutturato, ne vedremo delle belle, ancora più belle di quante ne abbiamo visto fino ad ora in termini di passi indietro, vigliaccheria e ipocrisia. Ma proviamoci, c’è poco da perdere, in ogni caso la complicità stabilita tra persone che condividono quotidianamente un ufficio, dove era prevista solo atomizzazione e competizione al ribasso coltivate per anni, arrivismo e genuflessione, è già un risultato. Per quanto mi riguarda, ho già deciso di cercare altrove i miei soldi, che ne ho le palle piene, ma almeno voglio farlo dopo aver misurato un po’ di forza collettiva dove c’è, al solito, solo frustrazione ed isolamento. Nella stesura di queste brevi note seguirò dei punti, per mostrare come l’inconsistenza soddisfatta di sé della mobilitazione universitaria fino ad oggi sia lo specchio fedele, dai tratti solo un po’ più marcati, dei caratteri principali dell’odierna militanza radicale con tutte le sue storture: autopromozione, capitale sociale, analfabetismo etico, opportunismo, totale sfiducia nichilista nella possibilità di una strategia efficace che non miri a un risultato simbolico in vista da qualcosa d’altro, ma a costruire una forza collettiva. Tutti questi tratti ricalcano piuttosto fedelmente, cercherò di evocarlo lungo il testo, i lineamenti antropologici tipici dell’ambiente universitario.
- Composizione, convergenza, strategia: «non possiamo protestare solo per la nostra condizione, sarebbe corporativo ed egoista». La frase precedente ha di che lasciare incredulo chiunque conosca anche solo approssimativamente la storia dei conflitti e delle forme di insubordinazione popolare che ci hanno preceduto, compresa la lunga stagione del cosiddetto movimento operaio. È una frase che contraddice qualsiasi basilare assunto materialista nel senso più vitale e bello del termine, quello che significa partire dal proprio quotidiano, la propria vita, i propri affetti, bisogni, desideri, anche con quel sano egoismo proletario che ha reso possibile, sempre, qualsiasi lotta degna di questo nome. È una frase idealistica, moralista, essenzialmente stupida, che stupisce ancora di più perché passata di bocca in bocca tra ricercatori precari che hanno spesso alle spalle lunghi anni di militanza nei circoli e centri sociali della cara sinistra “antagonista” (che cosa voglia dire è un mistero che supera le mie capacità) e perfino “autonoma”. E tuttavia eccoci: dalla rude razza pagana al senso di colpa generalizzato, con risultati più evidenti ogni giorno. Pensate se i militanti rivoluzionari degli anni ’60, solo per fare un esempio, fossero andati in Piazza Statuto a dire che la difesa contro gli attacchi padronali era uno sporco problemuccio egoista di quelli che si vedono ogni giorno, da dignificare con un’infusione di temi geopolitici e antiimperialisti. Convergenza delle lotte, composizione. Pensate, ancora, se durante uno sciopero selvaggio, talvolta portato avanti da operai che erano anch’essi comunisti e rivoluzionari, si fosse detto: ampliamo il campo, queste istanze sono troppo particolariste.
Non che nella storia di queste lotte i militanti più radicali ignorassero la necessità di connettere i fronti di attacco, le traiettorie di insubordinazione, che il modo di produzione di ricchezza e soggettività, lo sappiamo, è uno e soltanto uno, ma queste connessioni vanno raggiunte ed evidenziate approfondendo l’intensità della lotta come esperienza condivisa, non come ricettina da imporre normativamente agli interessi di chi lotta. Altrimenti siamo nel campo delle formule ideologiche, non solo sbagliate ma dannose. Allo stesso tempo la squalifica dell’egoismo sociale in nome del bene comune e dell’interesse generale è, da sempre, la ragione di chi le ribellioni vuole reprimerle, in particolare quando vuole reprimerle da sinistra. Si può conoscere veramente il tutto soltanto dal punto di vista di una parte, conosce veramente solo chi veramente lotta, diceva su per giù il senatore Tronti prima di raggiungere più miti consigli. Messa giù in modo ancora più concreto: un presidio per la difesa del lavoro dei precari in cui campeggino decine di bandiere della Palestina, materiale femminista, volantini contro il riarmo, non serve alla vertenza dei precari, ma neanche a queste cause. A chi serve? Ai militanti che vogliono prolungare il più possibile una mobilitazione inconcludente per riprodursi anno dopo anno come agenti (eternamente sconfitti) delle mobilitazioni altrui.
- Le parole e i fatti, o di cosa sia una sconfitta. Abbiamo bloccato il campus, lo sciopero è stato una vittoria straordinaria, abbiamo costruito assemblee precarie ovunque. Queste frasi si sono sentite ripetere in modo intercambiabile e in ordine sparso lungo tutto il corso dell’anno passato, con un retrogusto sempre più amaro e paradossale nel corso dei mesi, col profilarsi di una radicale espulsione dall’università di centinaia di ricercatori e ricercatrici precari. Si tratta di quel trionfalismo generalizzato dell’attivismo social in cui la pressione a fingere euforicamente la vittoria – fake it until you make it – impedisce di fare il più elementare bilancio delle sconfitte, producendo un distacco patologico rispetto alla realtà percepibile. Uno schermo tra il sé e il mondo che porta a ripetere da decenni le stesse modalità di lotta benché provochino puntualmente le stesse sconfitte. Inutile dirlo: la bolla universitaria acutizza ancora di più, se possibile, questo genere di amputazione della sensibilità. “Abbiamo bloccato il campus”, perché è quanto hanno scritto i giornali riprendendo i post su Instagram, nonostante l’attività didattica sia ripresa dopo pochissime ore di intralcio parziale e limitato nell’orario di minore affluenza. Un blocco, lo si chiama, e le parole perdono sempre più di senso. Uno sciopero con adesioni bassissime tra i precari e un’assenza pressocché totale degli strutturati è vittorioso, malgrado ogni evidenza, perché si tengono insieme i pezzi delle logiche militanti che lo hanno preparato. Lo stesso docente “impegnato” che proclama in aula il proprio sostegno allo sciopero non salta la lezione perché non riuscirebbe a recuperare le ore di didattica: segno di un livello di disponibilità al conflitto, al rischio, di rapporti di forza che stanno sotto lo zero. Quel che è peggio: la vita nei dipartimenti continua come se nulla fosse, mentre persone con cui condividevamo il tavolo improvvisamente spariscono, rimangono a casa, non se ne sa più niente e ce ne si disinteressa. Questa vita quotidiana sotto anestetico prosegue invariata sotto la stessa finzione e senza neppure più una piccola bussola. Chi ti ha promesso il contratto e ti ha sfruttato per poi lasciarti a casa è, secondo il galateo accademico, un collega e non uno sfruttatore. Siamo tutti nella stessa barca e subiamo tutti gli stessi processi impersonali, i bastardi non esistono. Se nel frattempo un uomo di quarant’anni in piena salute è stroncato da un attacco di cuore pochi giorni dopo che la stabilizzazione contrattuale promessa gli sfuma davanti agli occhi, fingeremo che sia per cause fisiologiche e che tutto il resto non abbia attinenza. Nessuno è responsabile e ci premureremo di ricordarlo dedicando alla sua memoria un arbusto (esattamente) nel cortile universitario, comportandoci come se non fosse un insulto al più basilare senso di decenza. Riempire i muri del dipartimento con manifesti e meme che dicano apertamente come stanno le cose, chi è il privilegiato e chi è sfruttato, è un piccolo gesto di igiene che può cambiare gli equilibri psicologici a cui ci hanno abituato. Ginnastica morale. Ma non basta, perché riconoscere i bastardi e dire che sono dei bastardi è il gesto etico e politico più elementare, da cui comincia tutto.
- I compagni di lotta non sono sempre (quasi mai) quelli che ti aspetti: di come gli habitus militanti abbiano distrutto ogni istinto salutare e la complicità non segua linee ideologiche. C’è un dato epocale oltremodo evidente a chi abbia occhi per vedere: di questi tempi chi è socializzato politicamente rappresenta, di solito, la parte peggiore di chi è coinvolto nelle mobilitazioni di protesta e nelle lotte. L’università non fa eccezione. Peggiore per un ampio novero di ragioni: ideologismo, attaccamento a schemi organizzativi e metodi di intervento largamente squalificati dall’esperienza, volontà di riproduzione della propria sigla organizzativa a discapito di qualsiasi crescita reale della forza collettiva, totale impermeabilità al lasciarsi toccare dagli incontri, il vissuto, quello che nelle situazioni di lotta è l’imprevisto e l’aleatorio. Cosa vuol dire questo in termini banalmente pratici? Se ciò che privilegio nell’incontro e nella costruzione singolare e situata di un collettivo è sempre ciò che esiste già da prima – discorsi, identità, piattaforme, logiche di rappresentazione politica e conventicola – sarò mosso da una sostanziale sfiducia nelle relazioni che avvengono dentro il collettivo e, soprattutto, sarò disposto a sacrificare le finalità immediate e circoscritte, ma così vitalmente essenziali per chi le porta avanti, in nome della temporalità più lunga e presuntamente ampia della mia prospettiva politica. Non importa che la lotta vinca, ma che la mobilitazione continui il più possibile.
Il tutto, lo abbiamo già detto, sconta però il fatto che questa prospettiva più ampia non esista, che i gruppi e gruppetti protagonisti di queste logiche siano totalmente incapaci di parlare a chiunque sia fuori da ambienti giornalistici, della politica istituzionale e di qualche circolo accademico, magari capace, connessione dopo connessione, anche di impiegare il proprio capitale sociale per favorire qualche carriera (siamo laici!). Avremo però il ricercatore precario che un giorno si sveglia, dopo aver evitato per mesi le lunghe assemblee inconcludenti che giustamente percepiva come inutili, e dice quello che vede: “diamoci una mossa, se no rimaniamo con il culo a terra, blocchiamo tutto e pure subito perché già siamo in ritardo!”. Questo individuo qualunque che non conosce la grammatica dell’attivismo radicale e postmoderno, sarà trattato prima con accondiscendenza, poi se persiste con fastidio e se proprio necessario si tenterà di ammansirlo. Ma come si permette di arrivare solo ora? E dove stava quando abbiamo spesso ore e ore in assemblea (ascoltandosi compiaciuti mentre si sparava un monte inverosimile di cazzate)? Questa persona che non è mai entrata in un centro sociale dice la verità, fa quello che andava fatto. E nella misura in cui è disposta a comportarsi di conseguenza è un alleato più utile del saccente marxista di turno. Allo stesso modo la collega con cui avevamo stretto rapporti scarsi durante gli anni di dottorato e precariato, appena salutandoci e ignorandoci reciprocamente, come si conviene al luogo, può rivelarsi più attenta alla nostra stanchezza, alla nostra esasperazione e alla nostra rabbia quotidiana, di tutti i militanti in circolazione. E più incazzata e depressa per lo schifo che le tocca vedere, a cui deve sottoporre le cose che ama studiare. Questa attenzione può esprimersi anche solo chiedendo sempre, inesorabilmente “Tu come stai?”. Le chiacchiere e stronzate scambiate quotidianamente alla macchinetta del caffè con un simpatico sociologo quantitativo (parlo sul serio), anche un po’ socialdemocratico, si coloriscono di un altro valore e di un’altra vicinanza. E questo è il dato prezioso su cui si può forse costruire qualcosa. Percepire delle evidenze, riflettere, condividerle e crederci insieme, poi agire di conseguenza. In fondo anche in un posto di merda si può stare bene, se si hanno degli amici.
- Avevo anticipato che questo scritto sarebbe stato uno sfogo, e infatti lo è stato. I toni e il taglio sono piuttosto differenti dai contributi che appaiono a singhiozzo su Nigredo, più concentrati su nodi teorici o riflessioni di prospettiva rivoluzionaria che su racconti esperienziali. Ma anche questo serve, a prendere l’abitudine di non considerare troppo banale, insulso, poco rilevante, quello che ci capita giorno per giorno nelle nostre vite. Quali che siano le conclusioni, sono perfettamente consapevole che le complicità strette in un momento di emergenza ed eccezione – di sospensione della normalità, per quanto infelice – non sono necessariamente destinate a durare. Ugualmente è chiaro che la logica del gruppo chiuso, dell’interesse e dell’opportunismo, parafrasando il linguaggio di Fachinelli, attecchisce e riaffiora più facilmente del suo contrario. La condizione specifica dei lavoratori dell’università non sarà in grado, probabilmente, di innescare una forza di rifiuto tale da infrangere i rapporti di forza e far arretrare il governo, e questo non è interamente imputabile a quella sottospecie antropologica in estinzione che sono i militanti politici radicali. In questo ciclo storico di importanti tensioni controrivoluzionarie, in cui lo spazio pubblico sembra interamente sotto il controllo del nemico, di destra e di sinistra, non si può sapere mai dove volgersi per trovare un moto di dignità, un soggetto disposto a ribellarsi. Come scriveva Mascolo, l’unica certezza è quella di continuare a tracciare la linea invalicabile – situazione per situazione, giorno per giorno – tra chi usa la parola per ingannarsi e ammantare il proprio egoismo di discorsi di valore e, dall’altra parte, chi crede a quello che dice.